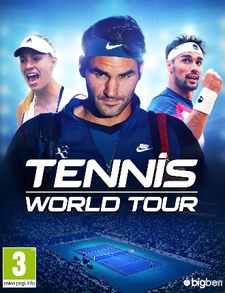Recensione
Possono bastare un’idea discreta e un ottimo contorno per trasformare uno spunto interessante in un prodotto di qualità? La scommessa di Ichiro Okouchi e soci su Kabaneri of the Iron Fortress pare basarsi proprio su questo, la supremazia della tecnica sul contenuto, una tendenza che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede nel mondo dell’animazione made in Japan; fermandoci a considerare solo le opere dello sceneggiatore in questione, Okouchi, spicca tra tutte Guilty Crown, delizioso gioiello di tecnica, tuttavia riassumibile in due sole parole: soldi sprecati. Nonostante il caso di Kabaneri non sia tanto disperato, lo stratagemma è lo stesso, si ubriaca di azione e colpi di scena lo spettatore allocco senza che egli si renda conto che, tolto quello, ciò che rimane di sostanza è poco o nulla.
L’idea c’è e, nonostante possa delinearsi come poco innovativa, riesce a stuzzicare in qualche modo la curiosità dello spettatore potenziale. Un Giappone dilaniato dalla comparsa di mostri simili a zombie, chiamati kabane; un sistema di città-fortezze protette da alte mura e collegate tra loro da un imponente sistema di rotaie; un universo steampunk fatto di mastodontici treni a vapore corazzati, valvole, ingranaggi e caldaie che cigolano e stridono a ogni movimento, condito da quell’immancabile tocco di “sporco” che conferisce al tutto una buona dose di credibilità. Dei kabane si sa poco in partenza, ed è amareggiante constatare che, pure col passare degli episodi, poco si continui a sapere; sono bestie antropomorfe dalla forza sovrumana, prive di ragione, che cacciano gli esseri umani per cibarsene, trasformandoli a loro volta in altri kabane.
Le disavventure del protagonista della serie, Ikoma, iniziano quando i kabane invadono la fortezza dove egli vive e lavora come operaio presso la ferrovia; morso da uno di questi, riesce a scampare la mostruosa metamorfosi piantandosi qualche chiodo nel corpo e bloccandosi la gola con un collare metallico, per fare in modo che il virus dal quale è stato infettato non si propaghi fino al cervello; un metodo poco ortodosso, ma a quanto pare molto efficace. Per farla breve, quello raggiunto da Ikoma è uno stadio ibrido tra l’essere umano e il kabane, un individuo con una resistenza e capacità rigenerativa fuori dal comune, ma costretto a nutrirsi di sangue per placare la fame animalesca: in una parola è diventato un “kabaneri”. Ad accompagnarlo nel suo viaggio verso la speranza di una nuova vita sarà Mumei, ragazza dall’aspetto innocente e un po’ infantile - moe potremmo dire - che a dispetto delle apparenze è una kabaneri anch’essa, abile combattente e spietata macchina di morte.
Fin dai primi minuti lo spettatore è catapultato nel vivo dell’azione, tra scontri a fuoco, pasti sanguinosi e macelli spietati, mai un calo di tensione, mai un attimo per ragionare, si pensa solo alla sopravvivenza. La precisione delle animazioni, la fotografia ad effetto, i toni caldi dei tramonti e le ombre del crepuscolo, la perizia della regia nelle scene tachicardiche e la cura del design dei personaggi mettono in luce fin da subito il punto di forza della serie, la capacità di mantenere viva sulla grafica l’attenzione dello spettatore, distratto, per così dire, solo dalla colonna sonora composta da Hiroyuki Sawano, ancora una volta valore aggiunto all’opera. Un inizio col botto, si potrebbe pensare, o forse un inizio furbesco. Il problema fondamentale è che, oltre la facciata, si palesa il vuoto: non appena le legnate lasciano spazio ai dialoghi, emergono tutti i problemi di una sceneggiatura banale e poco coerente. Pecca di superficialità, essenzialmente, troppo pregna di retorica spiccia - strizzando l’occhio ai battle shonen all’ultimo grido - e mai veramente coinvolgente da un punto di vista tematico o anche retorico; la regia di Araki similmente non riesce a comunicare e funzionare altrettanto bene e finisce per appesantire ancor più il prodotto e mettere in luce tutte le mancanze e le colpe di Okouchi a livello di intreccio e di sviluppo. Ma non finisce qui: manca un antagonista credibile - quello principale è prima paladino della giustizia, poi incarnazione del male sulla Terra, infine redento salvatore; stride terribilmente poi, seppur tra gli ultrasuoni, la dicotomia tra il lato “badass” di Mumei in versione arma finale e quello "very extra moe" negli spezzoni slice of life, risultando semmai un’emulazione deforme della Lucy di "Elfien Lied", insomma, l’ennesimo specchio per le allodole accalappia-otaku, uno di quelli che ultimamente va per la maggiore; nemmeno il doppiaggio riesce a salvarsi, con quelle urla e quel tono pomposo che tentano di conferire pathos ed epica anche a scene che non ne dovrebbero avere, inutile ripetere il motivo.
Quello che, sotto questa nuova luce, non si può perdonare a Okouchi, Araki e compagnia è il fare rinunciatario, il non osare a sufficienza e rifugiarsi nella mediocrità che tira, pur di avere un pubblico sicuro. Il risultato è la forzatura, che, nel tentativo di limitare le scene rilassate, percorrendo quindi la strada dei colpi di scena e dei cliffhanger, e smarrendo di contro quella della coerenza, viene portata a galla in tutta la sua possanza. Alla fine della visione, quel che resta di salvabile è poco di fronte alle incongruenze dell’intreccio e al suicidio logico della sceneggiatura. Per rispondere alla domanda iniziale, no, non bastano un’idea e un buon contorno, è necessario uno sviluppo quanto meno coerente e la voglia di osare, nella consapevolezza dei propri mezzi, per creare qualcosa di diverso, che non sappia di già visto.
Kabaneri of the Iron Fortress è un’opera insufficiente, più furbesca che pretenziosa, nel fare dell’intrattenimento fine a sé stesso - e a scapito del resto - la sua unica ragione di esistere; un tipo di animazione che personalmente non solo non amo, ma neanche giova al mercato, saturo ormai di queste operucole plasmate ad hoc per accontentare le masse.
L’idea c’è e, nonostante possa delinearsi come poco innovativa, riesce a stuzzicare in qualche modo la curiosità dello spettatore potenziale. Un Giappone dilaniato dalla comparsa di mostri simili a zombie, chiamati kabane; un sistema di città-fortezze protette da alte mura e collegate tra loro da un imponente sistema di rotaie; un universo steampunk fatto di mastodontici treni a vapore corazzati, valvole, ingranaggi e caldaie che cigolano e stridono a ogni movimento, condito da quell’immancabile tocco di “sporco” che conferisce al tutto una buona dose di credibilità. Dei kabane si sa poco in partenza, ed è amareggiante constatare che, pure col passare degli episodi, poco si continui a sapere; sono bestie antropomorfe dalla forza sovrumana, prive di ragione, che cacciano gli esseri umani per cibarsene, trasformandoli a loro volta in altri kabane.
Le disavventure del protagonista della serie, Ikoma, iniziano quando i kabane invadono la fortezza dove egli vive e lavora come operaio presso la ferrovia; morso da uno di questi, riesce a scampare la mostruosa metamorfosi piantandosi qualche chiodo nel corpo e bloccandosi la gola con un collare metallico, per fare in modo che il virus dal quale è stato infettato non si propaghi fino al cervello; un metodo poco ortodosso, ma a quanto pare molto efficace. Per farla breve, quello raggiunto da Ikoma è uno stadio ibrido tra l’essere umano e il kabane, un individuo con una resistenza e capacità rigenerativa fuori dal comune, ma costretto a nutrirsi di sangue per placare la fame animalesca: in una parola è diventato un “kabaneri”. Ad accompagnarlo nel suo viaggio verso la speranza di una nuova vita sarà Mumei, ragazza dall’aspetto innocente e un po’ infantile - moe potremmo dire - che a dispetto delle apparenze è una kabaneri anch’essa, abile combattente e spietata macchina di morte.
Fin dai primi minuti lo spettatore è catapultato nel vivo dell’azione, tra scontri a fuoco, pasti sanguinosi e macelli spietati, mai un calo di tensione, mai un attimo per ragionare, si pensa solo alla sopravvivenza. La precisione delle animazioni, la fotografia ad effetto, i toni caldi dei tramonti e le ombre del crepuscolo, la perizia della regia nelle scene tachicardiche e la cura del design dei personaggi mettono in luce fin da subito il punto di forza della serie, la capacità di mantenere viva sulla grafica l’attenzione dello spettatore, distratto, per così dire, solo dalla colonna sonora composta da Hiroyuki Sawano, ancora una volta valore aggiunto all’opera. Un inizio col botto, si potrebbe pensare, o forse un inizio furbesco. Il problema fondamentale è che, oltre la facciata, si palesa il vuoto: non appena le legnate lasciano spazio ai dialoghi, emergono tutti i problemi di una sceneggiatura banale e poco coerente. Pecca di superficialità, essenzialmente, troppo pregna di retorica spiccia - strizzando l’occhio ai battle shonen all’ultimo grido - e mai veramente coinvolgente da un punto di vista tematico o anche retorico; la regia di Araki similmente non riesce a comunicare e funzionare altrettanto bene e finisce per appesantire ancor più il prodotto e mettere in luce tutte le mancanze e le colpe di Okouchi a livello di intreccio e di sviluppo. Ma non finisce qui: manca un antagonista credibile - quello principale è prima paladino della giustizia, poi incarnazione del male sulla Terra, infine redento salvatore; stride terribilmente poi, seppur tra gli ultrasuoni, la dicotomia tra il lato “badass” di Mumei in versione arma finale e quello "very extra moe" negli spezzoni slice of life, risultando semmai un’emulazione deforme della Lucy di "Elfien Lied", insomma, l’ennesimo specchio per le allodole accalappia-otaku, uno di quelli che ultimamente va per la maggiore; nemmeno il doppiaggio riesce a salvarsi, con quelle urla e quel tono pomposo che tentano di conferire pathos ed epica anche a scene che non ne dovrebbero avere, inutile ripetere il motivo.
Quello che, sotto questa nuova luce, non si può perdonare a Okouchi, Araki e compagnia è il fare rinunciatario, il non osare a sufficienza e rifugiarsi nella mediocrità che tira, pur di avere un pubblico sicuro. Il risultato è la forzatura, che, nel tentativo di limitare le scene rilassate, percorrendo quindi la strada dei colpi di scena e dei cliffhanger, e smarrendo di contro quella della coerenza, viene portata a galla in tutta la sua possanza. Alla fine della visione, quel che resta di salvabile è poco di fronte alle incongruenze dell’intreccio e al suicidio logico della sceneggiatura. Per rispondere alla domanda iniziale, no, non bastano un’idea e un buon contorno, è necessario uno sviluppo quanto meno coerente e la voglia di osare, nella consapevolezza dei propri mezzi, per creare qualcosa di diverso, che non sappia di già visto.
Kabaneri of the Iron Fortress è un’opera insufficiente, più furbesca che pretenziosa, nel fare dell’intrattenimento fine a sé stesso - e a scapito del resto - la sua unica ragione di esistere; un tipo di animazione che personalmente non solo non amo, ma neanche giova al mercato, saturo ormai di queste operucole plasmate ad hoc per accontentare le masse.
News