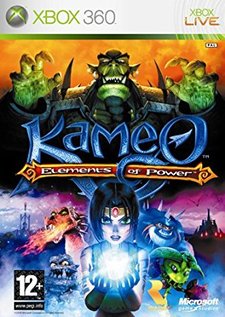Recensione
Suicide Club
7.5/10
Recensione di traxer-kun
-
Tokyo, primi anni Duemila. Una squadra speciale della polizia indaga su una tendenza che sta prendendo piede negli ultimi tempi tra i giovani Giapponesi: quella di mettere in atto dei veri e propri suicidi di massa, in cui nutriti gruppi di adolescenti si tolgono la vita con una sconcertante quanto agghiacciante indifferenza, nelle modalità e nei luoghi più disparati. Credendo che dietro a tutto ciò ci sia un vero e proprio culto istigatore, il detective Kurada - indirizzato da una ragazza nota sulle community online con il nickname di Kōmori ("Pipistrello") - inizia a seguire la pista di un misterioso sito internet che riporta quotidianamente il numero delle vittime; nel frattempo un nuovo gruppo j-pop composto da cinque ragazzine inizia a fare le sue prime apparizioni televisive, riscontrando in tutto il Giappone un successo clamoroso.
Suicide Club, lungometraggio del 2001 ormai adibito allo status di cult movie, è stato il film che ha consacrato il suo regista Sion Sono e che l'ha lanciato sulla scena mondiale, complice anche un notevole successo ottenuto in patria, che ha permesso persino la nascita di un libro e di un manga ad esso ispirati - quest'ultimo firmato nientemeno che dal talentuoso Usamaru Furuya, amico di vecchia data del regista. Ma la particolarità del film resta la sua stravagante e inquietante poetica, che si fa promotrice di una impietosa quanto sottile critica sociale.
Poniamo una premessa: la società giapponese, se vista da un'ottica "esterna", è ad oggi una delle più prospere e ricche del mondo, e negli ultimi anni è stata al centro di grandi progressi in campo economico e del benessere sociale. Ma dietro a questa maschera di efficienza e prosperità si cela un profondo disagio, che vede le sue radici proprio in quei valori capitalistici che hanno messo al centro il profitto economico e il consumismo; in altri termini, il Giappone ha assimilato tali valori in modo del tutto assoluto e incondizionato, giungendo a plasmare un organismo sociale omologato e competitivo, in nome della logica del mercato. Ma tutto ciò va a scapito del cittadino singolo, che spesso e volentieri vede i propri diritti di essere umano calpestati per il bene della collettività: i deboli, i falliti e tutti coloro che non riescono a stare al passo con la società sono messi da parte, e non è un caso che il Giappone sia uno dei Paesi con il più alto tasso di suicidi al mondo.
Il film, che a detta di Sion Sono dovrebbe essere parte di una vera e propria "trilogia dell'alienazione" in cui figura anche il successivo Noriko's Dinner Table, assume fin da subito un approccio enigmatico e frammentario, che non si risparmia passaggi onirici o minimali e continui cambi di focalizzazione dagli effetti destabilizzanti. Attraverso un confondente gioco di specchi, il regista costruisce una pellicola che fa della totale imprevedibilità il suo maggiore punto di forza: Suicide Club è un film di difficile catalogazione, che in prima battuta assume l'aspetto di un giallo a tinte horror, ma che tassello dopo tassello va a comporre un vero e proprio puzzle dai caratteri sconcertanti e rarefatti, che svelerà solo negli ultimi minuti la sconvolgente verità che nasconde l'intero intreccio. I numerosi piani sequenza si infiltrano e scavano tra la folla, scrutano nei corridoi, negli uffici, sui mezzi pubblici e in luoghi dove spesso la luce non filtra, mentre la macchina a mano indugia sui dettagli, sulle espressioni del viso, scandagliando l'animo marcio e irrequieto delle persone. Sion Sono, pur mettendo a fuoco l'ambiente schizofrenico e oppressivo della società - come avviene nella bellissima scena d'apertura, che evidenzia un lirismo tanto esasperato quanto nichilista -, si diverte a portare l'ignaro spettatore lungo piste false e mistificanti, impregnando tuttavia l'opera di continue strizzate d'occhio e messaggi subliminali. Perché è proprio lì che infine vuole arrivare: i suicidi sono solo la conseguenza e la soluzione di un processo di manipolazione a livello inconscio che vede le sue radici molto più a fondo; come peraltro avviene nella stessa struttura sintattica del film, che sfiorando le caratteristiche del metaracconto mette a nudo la follia collettiva dell'essere umano, imprigionato nel giogo della società e nello strapotere dei mass media, che ne azzerano il libero arbitrio a prescindere da una ragione precisa.
«Se mi dai un'opportunità, potrai dividere con me il sentimento che provo
E potrai riempire il baratro nel mio cuore
Insieme, possiamo versare luce sul buio
Può essere spaventoso, ma può anche renderti felice
Ora vuoi realmente dirmi addio e lasciarmi per sempre
[...]
Andandocene dimenticheremo il dolore, troveremo di nuovo la vita»
(Write Once - Dessert)
Ma mentre questa carica repressa e accumulata esplode e si ritorce contro alla società - la delirante violenza di Genesis e della sua banda di deviati dal look androgino ne è un valido esempio -, Sono ci conduce verso un finale nel quale, a sorpresa, si riesce ancora a intravedere un barlume di speranza: è la prova che uscendo volontariamente dalla spirale di passività e rassegnazione, un cambiamento - per quanto minimo - è di fatto possibile.
A costo di rinunciare alla coesione dell'intreccio, fattore di cui si avverte purtroppo la mancanza soprattutto verso metà pellicola, Suicide Club si fa promotore di un messaggio che ben poche opere possono eguagliare per originalità; contenuto che tuttavia non sempre è coadiuvato da una forma all'altezza, risentendo forse di un'eccessiva pesantezza data dal sovraccarico di intenti.
Suicide Club, lungometraggio del 2001 ormai adibito allo status di cult movie, è stato il film che ha consacrato il suo regista Sion Sono e che l'ha lanciato sulla scena mondiale, complice anche un notevole successo ottenuto in patria, che ha permesso persino la nascita di un libro e di un manga ad esso ispirati - quest'ultimo firmato nientemeno che dal talentuoso Usamaru Furuya, amico di vecchia data del regista. Ma la particolarità del film resta la sua stravagante e inquietante poetica, che si fa promotrice di una impietosa quanto sottile critica sociale.
Poniamo una premessa: la società giapponese, se vista da un'ottica "esterna", è ad oggi una delle più prospere e ricche del mondo, e negli ultimi anni è stata al centro di grandi progressi in campo economico e del benessere sociale. Ma dietro a questa maschera di efficienza e prosperità si cela un profondo disagio, che vede le sue radici proprio in quei valori capitalistici che hanno messo al centro il profitto economico e il consumismo; in altri termini, il Giappone ha assimilato tali valori in modo del tutto assoluto e incondizionato, giungendo a plasmare un organismo sociale omologato e competitivo, in nome della logica del mercato. Ma tutto ciò va a scapito del cittadino singolo, che spesso e volentieri vede i propri diritti di essere umano calpestati per il bene della collettività: i deboli, i falliti e tutti coloro che non riescono a stare al passo con la società sono messi da parte, e non è un caso che il Giappone sia uno dei Paesi con il più alto tasso di suicidi al mondo.
Il film, che a detta di Sion Sono dovrebbe essere parte di una vera e propria "trilogia dell'alienazione" in cui figura anche il successivo Noriko's Dinner Table, assume fin da subito un approccio enigmatico e frammentario, che non si risparmia passaggi onirici o minimali e continui cambi di focalizzazione dagli effetti destabilizzanti. Attraverso un confondente gioco di specchi, il regista costruisce una pellicola che fa della totale imprevedibilità il suo maggiore punto di forza: Suicide Club è un film di difficile catalogazione, che in prima battuta assume l'aspetto di un giallo a tinte horror, ma che tassello dopo tassello va a comporre un vero e proprio puzzle dai caratteri sconcertanti e rarefatti, che svelerà solo negli ultimi minuti la sconvolgente verità che nasconde l'intero intreccio. I numerosi piani sequenza si infiltrano e scavano tra la folla, scrutano nei corridoi, negli uffici, sui mezzi pubblici e in luoghi dove spesso la luce non filtra, mentre la macchina a mano indugia sui dettagli, sulle espressioni del viso, scandagliando l'animo marcio e irrequieto delle persone. Sion Sono, pur mettendo a fuoco l'ambiente schizofrenico e oppressivo della società - come avviene nella bellissima scena d'apertura, che evidenzia un lirismo tanto esasperato quanto nichilista -, si diverte a portare l'ignaro spettatore lungo piste false e mistificanti, impregnando tuttavia l'opera di continue strizzate d'occhio e messaggi subliminali. Perché è proprio lì che infine vuole arrivare: i suicidi sono solo la conseguenza e la soluzione di un processo di manipolazione a livello inconscio che vede le sue radici molto più a fondo; come peraltro avviene nella stessa struttura sintattica del film, che sfiorando le caratteristiche del metaracconto mette a nudo la follia collettiva dell'essere umano, imprigionato nel giogo della società e nello strapotere dei mass media, che ne azzerano il libero arbitrio a prescindere da una ragione precisa.
«Se mi dai un'opportunità, potrai dividere con me il sentimento che provo
E potrai riempire il baratro nel mio cuore
Insieme, possiamo versare luce sul buio
Può essere spaventoso, ma può anche renderti felice
Ora vuoi realmente dirmi addio e lasciarmi per sempre
[...]
Andandocene dimenticheremo il dolore, troveremo di nuovo la vita»
(Write Once - Dessert)
Ma mentre questa carica repressa e accumulata esplode e si ritorce contro alla società - la delirante violenza di Genesis e della sua banda di deviati dal look androgino ne è un valido esempio -, Sono ci conduce verso un finale nel quale, a sorpresa, si riesce ancora a intravedere un barlume di speranza: è la prova che uscendo volontariamente dalla spirale di passività e rassegnazione, un cambiamento - per quanto minimo - è di fatto possibile.
A costo di rinunciare alla coesione dell'intreccio, fattore di cui si avverte purtroppo la mancanza soprattutto verso metà pellicola, Suicide Club si fa promotore di un messaggio che ben poche opere possono eguagliare per originalità; contenuto che tuttavia non sempre è coadiuvato da una forma all'altezza, risentendo forse di un'eccessiva pesantezza data dal sovraccarico di intenti.